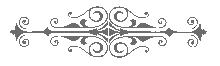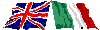| Home page | Sul sito | Storia | Persone | Natura | Archeologia industriale | Sport | Links |
| Scienziati | Religiosi | Nobili | Altri |
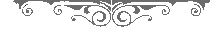
Ma dopo tutto...
Che roba è un referendum?
Ogni volta che viene fatto un referendum si scatena ogni storta di dibattito su ogni singolo dettaglio dell'argomento del giorno. E si dà sempre per scontato che l'esito del referendum abbia senso e debba essere rispettato.
Questa logica apparentemente ferrea si fonda su alcuni concetti, solitamente non dichiarati, che sono:
- Qualsiasi scelta va bene;
- Il cittadino gode del libero arbitrio;
- Delle questioni in essere tutti hanno a disposizione le stesse informazioni;
- Il significato del Si e del No. La risposta che viene data ha lo stesso significato per tutti;
- La rappresentatività statistica del voto. Il voto rappresenta correttamente il volere dell'intera popolazione.
- Che durata ha la decisione presa?
- Chi vince, vince?
- Quanti lo chiedono. Chi va a votare?
- Se il referendum servisse per sapere cosa vuole la gente...
Ergo?
Si tratta di "piccoli" postulati che forse sarebbe ora di analizzare. Ormai da troppo tempo si prendono “non decisioni” che ci inguaiano per decenni e non ci sforziamo di cercare la causa ultima del problema. Dal referendum italiano sul nucleare dietro al quale non c'erano soluzioni diverse per produrre energia al recente Brexit i cui fautori non si erano chiesti cosa avrebbero fatto in caso di vittoria, la storia recente è costellata di guai colossali causati da un modo di prendere decisioni che si postula essere sommamente democratico. Ma lo sarà?
Qualsiasi cosa va bene.
Presupposto non dichiarato di tutti i sistemi elettorali è che qualsiasi cosa si faccia, va sempre bene. Si presentano tanti partiti con idee diverse, voti quello che ti pare. Quello che fa va bene perché siamo in democrazia e ha vinto le elezioni.
Mi vien da pormi una domanda. Come mai quando abbiamo mal di denti non convochiamo elezioni democratiche nella quali tutti i cittadini possono essere eletti e diventare dentisti? Non è che l'oggettività, magri, valga qualcosa?
Se all'epoca di Galileo si fosse fatto un referendum sulla forma della terra, avrebbe senz'altro vinto la “il sole che gira intorno alla terra”. Ciò non di meno la terra avrebbe continuato a girare attorno al sole. E su questo concetto le previsioni del tempo non sarebbero state inventate, idem il GPS, idem i satelliti per telecomunicazioni e poi ancora.
Occorre affrontare la dura realtà. Non è tutto così semplice da essere risolto con crocette su Si & No. Perché un'idea funzioni occorre che sia oggettivamente corretta. Non serve crederci. Per un secolo si sono fatti “investimenti per il futuro” e adesso siamo sommersi di debiti e istituzioni a catafascio. Non era deprecabile l'ambizione, ma era tecnicamente e oggettivamente sbagliato quello che si faceva. Ed era sbagliato perché si perseguiva un'ideale invece che sforzarsi di capire la realtà.
I secoli passano ma il sole continua a girare attorno alla terra nonostante il disaccordo degli astronomi.
Il cittadino gode del libero arbitrio.
Chi ha colpa del suo mal, pianga se stesso! Un proverbio che sintetizza mirabilmente il concetto che una persona subisce le conseguenze delle sue scelte. Per la verità potrebbe goderne anche dei benefici, ma il proverbio non lo segnala.
È una cosa chiara e limpida. Talmente chiara e limpida che non occorre parlarne. Talmente universale che tutti i sistemi legislativi del mondo sono fondati su due concetti di base: tutte le persone di normale intelligenza hanno la stessa comprensione delle cose (solitamente è definita di normale intelligenza una persona con QI > 70); ogni persona può scegliere liberamente come comportarsi.
È un po' come quando "il sole girava attorno alla terra”. Talmente chiaro che non valeva la pena studiare l'argomento.
Ma forse sarebbe bene “scaricare qualche aggiornamento” nel bagaglio di conoscenze di uso quotidiano per scoprire che le neuroscienze nell'ultimo decennio hanno fatto passi da gigante. Mirabili le opere divulgative di David Eagleman su questo. È interessante – se non sconvolgente – scoprire come i comportamenti umani sono quasi tutti automatici e l'idea di avere in mano il controllo delle nostre azioni è solo illusoria. Fondamentali le conclusioni: non è al momento certo se il libero arbitrio esista oppure no. Ma se esiste ha certamente un ruolo talmente marginale che è difficile identificarlo a livello sperimentale.
Su queste basi ci viene chiesto di fare delle scelte. Come non bastasse che hanno effetti sugli altri e sul futuro.
Delle questioni in essere tutti hanno a disposizione le stesse informazioni.
Dato che la comunicazione è uguale per tutti, tutti sanno le stesse cose. Mmmhhh...
Chissà come mai succede di non capirsi?
Solitamente si considera che non più del 20% delle persone associa ad una parola lo stesso significato. Arrivederci quanto sono frasi intere. Peggio che andar di notte con concetti complessi. Gli esperimenti di neuroscienze ormai hanno evidenziato con dovizia di particolari che tante persone che guardano lo stesso quadro vedono cose completamente diverse; tante persone che ascoltano lo stesso discorso sentono cose completamente diverse... La realtà nella quale ognuno vive è virtuale ed è creata dal cervello in base a un'infinità di fattori tra i quali quello che veramente succede nel mondo ha un ruolo che non è necessariamente quello di protagonista.
La scienza esplora l'enorme complessità della natura. Il cervello umano è il più complicato oggetto singolo oggi conosciuto nell'universo! E la politica semplifica tutto a Si/No.
Quando cesseremo di illuderci che sia tutto semplice? Tutto facile? La realtà è complessa e, al contrario di quel che pensiamo, non abbiamo strumenti per percepirla. Il nostro cervello viaggia per i fatti suoi e noi abbiamo enormi difficoltà a imbrigliarlo e costringerlo a vedere l'oggettività e smontarla in concetti utili per stare meglio.
Per andare avanti abbiamo bisogno di scelte guidate dalla conoscenza; non dalle crocette.
Il significato del Si e del No.
“Si” e “No” sono le risposte chiare per antonomasia. Fin da bambini ci siamo sentiti dire in mille circostanze “o è Si o è No”.
Tralasciando il piccolo particolare che ci sarebbero mille gradazioni fra i due, diamo per buono il concetto che queste due risposte risolvano la questione e vediamo cosa vogliono dire con un esempio storico.
Negli anni '70 la comunità internazionale si è seduta attorno ad un tavolo per decidere se adottare il Sistema Internazionale di unità di misura che avrebbe risolto una lunga serie di problemi di uso delle vecchie unità ed avuto il merito di essere uguale per tutti. Una serie di paesi fra cui l'Italia ha aderito esprimendo dunque un chiaro “Si” mentre altri paesi, principalmente dell'area anglosassone, non hanno aderito dicendo quindi “No”.
Il bello di disporre di un fatto ormai vecchio di qualche decennio è che consente di vedere cosa è effettivamente successo in pratica.
Italia del “Si”.
Nessuna unità di misura è stata cambiata. Avete mai visto un termometro in Kelvin, un tachimetro in Metri al Secondo, l'energia venduta al Joule on un peso espresso in Newton?
Paesi del “No”.
Molte unità di misura SI sono diventate “de facto” di uso diffuso. Ormai è prassi che tutta la documentazione di ogni genere e natura sia con doppie unità, locali e internazionali, e sapendo di non aver aderito si accertano che tutti sappiano usarlo in modo da poter comunicare efficacemente a livello internazionale.
Ecco che il “Si” italiano rappresentava la messa in sequenza della lettera “s” e della lettera “i”, non la volontà di cambiare e aggiornarsi. Nessuna azione significativa è stata fatta per cambiare il sistema nell'uso legislativo, nella scuola né nelle comunicazioni.
Viceversa il “No” anglosassone esprimeva una qualche forma di ostilità o impossibilità ad aderire corredata della presa di coscienza che, facendolo gli altri, comunque sarebbe stato necessario aggiornare il modo di operare, cosa che hanno effettivamente fatto.
A me sembra tanto il il No anglosassone somigli a un Si molto più del Si italiano che in pratica è stato un No.
Cosa viene chiesto da un referendum? Di votare “Si” oppure “No”. Anche coloro che votano allo stesso modo hanno di fatto in mente una varietà enorme di concetti radicalmente diversi tra loro.
La rappresentatività statistica del voto.
Se la democrazia consiste nel prendere decisioni in nome e per conto, e nell'interesse dell'intera popolazione, allora il referendum deve produrre un risultato che sia effettivamente rappresentativo della volontà della popolazione.
Un fenomeno che si verifica ormai comunemente è: 1/3 della popolazione non va a votare; 1/3 della popolazione vota “Si”; 1/3 della popolazione vota “No”.
Le piccole oscillazioni intorno a questi macro numeri sono quelle che determinano il raggiungimento o no del quorum (ove esiste) e la vittoria di qualcuno.
Abramo Lincoln aveva già capito ciò che la moderna statistica riesce ad esplorare con grande dettaglio: in democrazia, qualsiasi cosa si dica, un terzo dell'opinione pubblica sarà contrario: 1/3.
La legislazione sui referendum solitamente ignora il volere di chi non va a votare salvo nel caso dei referendum con quorum nei quali il non andare a votare assume un certo valore. Questa prassi, dettata da ragioni di carattere pratico, comunque crea il problema che chi non va a votare fa parte della cittadinanza e ha delle posizioni che devono essere conosciute e rispettate altrimenti si ha un'onda di opposizione alla scelta che verrà fatta.
Dal punto di vista di “cosa dice” chi non va a votare il discorso sarebbe complesso ma si può ragionevolmente semplificare al fatto che, dato che i referendum nascono solitamente per spingere dei cambiamenti, chi non va a votare, o è fautore di lasciare le cose come sono o, quanto meno, non è particolarmente entusiasta di cambiarle. Per cui il “non voto” somiglia di più ad un “non cambiamo” che ad un “cambiamo”.
Con queste osservazioni, se guardiamo gli esiti dei referendum degli ultimi anni: gli esiti spesso si ribaltano!
Con 1/3 di “non voti”, dire che il 55% ha votato in un modo vuol solo dire che il 1/3 dei contrari di Lincoln è presente, cosa che sapevamo già senza fare il referendum. La microscopica minoranza che fa la differenza vincolerà l'intero paese al suo volere.
Nelle retrovie resta il 1/3 di non voti che andrebbero associati – se non tutti in buona misura – a quelle del “non cambiamo” dando vittorie possenti a chi di solito perde. Del resto è logico: vanno a votare prevalentemente quelli che hanno voluto il referendum; non gli altri.
Che durata ha la decisione presa?
Un tema mai discusso è che durata deve avere la decisione presa con un referendum. Dopo quanto tempo e con che mezzi può essere legittimamente presa una decisione diversa dall'indicazione referendaria?
Cambiare idea è, in generale, legittimo. In particolare, in un mondo che cambia rapidamente, le esigenze cambiano con rapidità impetuosa. Ognuno può rendersi conto di quante cose oggi considera ottime idee che solo poco tempo fa considerava deprecabili. Ma non bastano le opinioni soggettive. La scienza fa progressi rapidissimi che ci portano continuamente a capire oggettivamente che erano sbagliate cose che solo ieri ci sembravano corrette. Le invenzioni che derivano dai progressi della scienza scombinano continuamente le opportunità che abbiamo davanti e le modalità per sfruttarle. Abbiamo sempre più bisogno di estrema elasticità.
E in questo contesto ingessiamo il mondo con referendum dalla scadenza ignota. Nelle elezioni politiche il cambiamento è stato considerato dal legislatore con rinnovi di 4-5 anni. Ma nel referendum cosa facciamo? Ha senso continuare a doversi attenere a decisioni prese anni fa e ormai arcaiche? O magari da gente già morta da tempo?
Chi vince, vince?
Tutte le volte che si parla di democrazia si atterra irrimediabilmente sul concetto “la maggioranza vince”.
Che differenza da quando a scuola studiavo la nascita delle prime democrazie che originariamente significavano “governo del popolo”. Io avevo capito che le istituzioni dovevano soddisfare le esigenze di tutti i cittadini. Si vede che non ero attento...
Siamo d'accordo sul fatto che, in certi ambiti, per ragioni di carattere pratico occorre una scelta unica anche se non condivisa. Per esempio non so immaginare come si potrebbe permettere di guidare a destra oppure a sinistra in base alle preferenze personali... Però, le istituzioni che tutti paghiamo devono fare il possibile per soddisfare tutte le esigenze di tutti i cittadini, non solo quelle di alcuni neanche se “alcuni” sono la maggioranza. Tanto più quando è una maggioranza virtuale fatta di un uso erroneo dello strumento statistico.
Il numero di contrari, magari sommato di una bella fetta dei non votanti, esprime il numero di persone che saboterà chi vince che quindi non raggiungerà gli obiettivi che dice. Per avere successo occorre sviluppare consenso, non illudersi di trovare chi comanda confidando in un'obbedienza che non ci sarà mai.
Liquidando come scontato che “la maggioranza vince” ecco cosa succede. L'esito del voto è inficiato dalla questione generale della “rappresentatività statistica del voto”. Su questo si innesta una campagna elettorale che magari ottiene di spostare i voti dove vuole ma non di cambiare le idee alle persone. Conseguenza, l'esito del voto non c'entra nulla con ciò che la gente desidera con la complicazione che essendo guidato da una minoranza “de facto” la maggioranza sarà ostile alle conseguenze del voto inficiando qualsiasi possibilità di successo di quanto verrà fatto.
Chissà se questo spiega le conseguenze di molti referendum passati...
Quanti lo chiedono. Chi va a votare?
Il meccanismo referendario ha la caratteristica di essere innescato da minoranze estremamente esigue. Qualche centinaio di migliaia di firme su decine di milioni di aventi diritto al voto o poche azioni politiche.
Ne consegue un errore sistematico del dato dovuto al fatto che alla vasta maggioranza dei votanti semplicemente non ne importa nulla della questione e non ha alcuna intenzione di perdere tempo a documentarsi su una cosa che interessa solo ad una esigua minoranza. Andranno a votare per lo più quelli che hanno richiesto il referendum sbilanciando il risultato e togliendogli qualsiasi valore significativo.
A volte il problema viene liquidato che chi non va a votare non può farsi ragioni. Ma non è vero. Ritenere che un voto non abbia ragione di esistere è una posizione che ha la stessa dignità di tutte le altre e deve essere considerata correttamente nei dati.
Se il referendum servisse per sapere cosa vuole la gente...
Se il referendum fosse democratico, servirebbe per rilevare cosa vuole la popolazione. Per cui sarebbe sviluppato col fine di misurare con la massima precisione possibile l'entità delle diverse opinioni esistenti.
Ma soprattutto, la politica non interverrebbe in alcun modo! Nessun politico si sognerebbe anche solo di esprimere un'opinione.
Invece scatta la predicazione, lo sforzo indottrinante, la caccia agli argomenti a sostegno della tesi. L'obiettivo non è sapere cosa vuole la gente ma convincerla a dire di volere ciò che vuole il politico...
Ergo?
Preso atto di tutto ciò: cosa vuol dire l'esito del referendum? Nulla. Zero. Niente. Fuffa. Aria fritta. Buttare i dadi.
Continuiamo ad illuderci che cavalcare luoghi comuni arcaici e difenderli fino alla morte sia il modo corretto per andare avanti. E restiamo al palo.
Con le conoscenze di oggi la qualità della vita potrebbe aumentare in modo iperbolico senza neanche fare scelte sconvolgenti. Ma occorre un po' di coraggio e spirito pionieristico per capire che:
- La realtà è complessa e occorre faticare per capirla;
- Il responsabile dei nostri guai non si vede dalla finestra ma allo specchio;
- Non troveremo nel passato la soluzione ai problemi de futuro;
- I nostri problemi ce li risolviamo lavorando sodo; non delegando chissà quale potere a chissà quale fantomatico nostro rappresentante e nume tutelare;
- Occorre stanare le migliori menti e collocarle dove le loro conoscenze danno maggiori frutti;
- Occorre smetterla di difendere bandiere e concentrarsi su cercare la soluzione a problemi;
- Occorre capire che i guai non hanno necessariamente un colpevole. Solitamente sono questioni del tutto naturali e null'altro che situazioni da gestire e problemi da risolvere.
Ora mi si potrebbe chiedere: perché passi il tempo ad analizzare cose simili?
Perché la vita non è infinita e non intendo semplicemente aspettare un futuro migliore né mi accontento di sognarlo. Voglio fare la mia parte per ottenerlo abbastanza in fretta da poterne ancora trarre beneficio...
E allora ecco che cerco di fare e di ottenere mettendoci del mio, coinvolgendo e condividendo il mio entusiasmo per la scienza che illumina il buio.
Vorrei condividere mille pensieri ed osservazioni ma proverò a sintetizzare focalizzando l'attenzione su un obiettivo che – per il metodo con cui è perseguito - è fortemente rappresentativo di tutti.
Aver capito che, di fatto, non si sa bene cosa sia la realtà e che il libero arbitrio non esiste o, ben che vada, poco ci manca, scardina tutti i meccanismi su cui sono fondati tutti i sistemi del mondo. Finalmente stiamo cominciando a capire cosa c'è nelle fondamenta di tutto ciò che non funziona nei sistemi sociopolitici creati nella storia dell'umanità.
Il più bell'esempio che conosco dello sforzo di fare un sostanziale passo in avanti è qui:
http://www.eaglemanlab.net/neurolaw
Il neuroscienziato David Eagleman ha lanciato un progetto che unisce neuroscienziati, legali e politici per ri-inventare un sistema legale basato su come siamo fatti invece che su come pensiamo di essere.
Splendido esempio di lavoro di team che unisce esperti delle diverse discipline con l'obiettivo comune di sviluppare qualcosa che funziona.
E concludo prendendo in prestito un pensiero dal mio amico Paolo.
Un aeroplano è una macchina di una complessità enorme. Per funzionare occorre che funzioni un grande numero di infrastrutture a loro volta complicatissime. Nonostante questo gli aeroplani volano regolarmente e sono il mezzo di trasporto più sicuro del mondo.
Come mai?
Perché la moltitudine di persone che si occupa di ogni singolo dettaglio ha un obiettivo comune. Fare in modo che gli aerei volino. E per farlo non corrono dietro a zuffe ideologiche ma ognuno usa al meglio le migliori conoscenze disponibili nel suo ambito.
Dobbiamo imparare a fare lo stesso con il mondo. Ci toccherà faticare per imparare, faticare per capire e tribolare nella complessità. Ma se ci scrolliamo di dosso la logica del Si/No e usiamo al meglio le migliori conoscenze, allora prenderemo il volo...