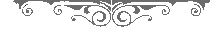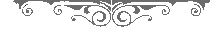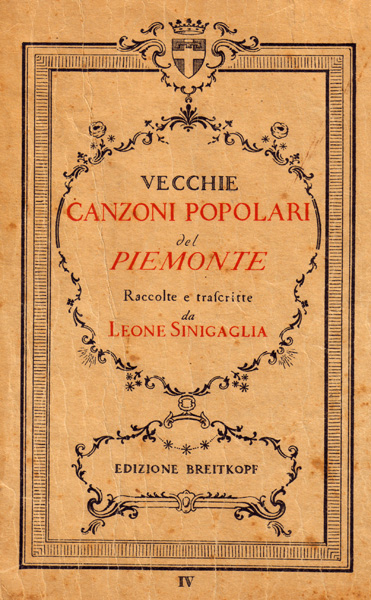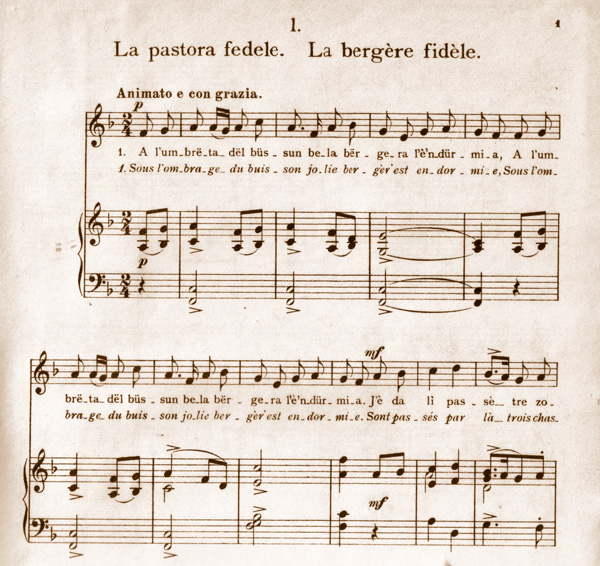Leone Sinigaglia all'epoca del suo soggiorno a Vienna (1895-1899).
Già in questi primi anni di studio Sinigaglia si dedicò assiduamente
alla composizione. Nel 1891, al Teatro Vittorio Emanuele di Torino, il
suo maestro, Giovanni Bolzoni, gli diresse un intero concerto di
musiche orchestrali. L'esito fu lieto, ma più tardi Sinigaglia condannò
all'oblio sia queste opere sia quelle cameristiche contemporanee.
Verso la fine del 1894 Sinigaglia si recò a Vienna, per approfondire
gli studi di contrappunto e di composizione sotto la guida del dotto
Eusebius Mandyczewski, archiviarlo del Musik-Verein e grande amico di
Johannes Brahms.
Durante il soggiorno viennese, Sinigaglia incontrò spesso Brahms, che
ebbe per lui molta simpatia, e poté ascoltare i grandi direttori
d'orchestra Hans Richter, Gustav Mahler e Felix Weingartner, oltre ai
più celebri solisti dell'epoca. Conobbe anche musicisti di fama, tra
cui Karl Goldmark e Anton Dvorak, il quale gli diede per qualche tempo,
a Praga, lezioni di orchestrazione.
Nel 1899, ritornò in Italia, stabilendosi definitivamente a Torino,
nella casa di Cavoretto, e iniziò la sua attività vera e propria di
compositore.
Le sue opere, orchestrali e camerali, in breve tempo si diffusero nelle
principali sale da concerto d'Europa e d'America e vi rimasero
stabilmente in repertorio. Fra le più note ricorderemo: la Romanza e
Humoreske per violoncello e orchestra; il Concerto in la maggiore, la
Romanza, la Rapsodia piemontese e il Rondò per violino e orchestra; il
Quartetto in re maggiore, le Variazioni su un tema di Brahms e i Due
pezzi caratteristici per quartetto d'archi; il Trio-Serenata per
violino, viola e violoncello; le Danze piemontesi, l'ouverture Le
Baruffe Chiozzotte, la suite Piemonte e il Lamento per orchestra; la
Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte; la Sonata in sol
maggiore per violino e pianoforte; i Duetti, le Romanze, i Tre Canti.
Fra i grandi direttori d'orchestra, che più volte le presentarono,
figurano i nomi di Toscanini, Nikisch, Mahler, Weingartner,
Furtwängler, De Sabata, Guarnieri.
Intorno al 1902 Sinigaglia cominciò a raccogliere sistematicamente i
canti popolari della collina di Cavoretto, utilizzandone alcuni, per la
prima volta, nelle Danze piemontesi op. 31, eseguite nel 1903, sotto la
direzione di A. Toscanini, al Teatro Vittorio Emanuele, ed accolte
burrascosamente dal pubblico e dalla critica.
Sinigaglia utilizzò direttamente i canti popolari in composizioni
sinfoniche soltanto altre due volte: nella suite Piemonte op. 36 (1910)
e nella Serenata sopra temi popolari op. 30 (postuma).
Sulla collina di Cavoretto, il musicista torinese raccolse, nel corso
di lunghi anni di ricerche non sempre facili, un gran numero di canzoni
pressoché scomparse (oltre 500 tra melodie e varianti), di cui solo
qualche «vecchia donna» conservava la memoria.
Parte di queste canzoni, 36 per l'esattezza, elaborate per canto e
pianoforte dal 1907, furono pubblicate dall'editore tedesco Breitkopf,
in successive raccolte (1914-1927), sotto il titolo Vecchie Canzoni
popolari del Piemonte (nuova edizione, Ricordi, Milano 1957). Una
ulteriore raccolta di 24 canzoni apparve, postuma, a cura di Luigi
Rognoni, presso l'editore Ricordi, nel 1956.
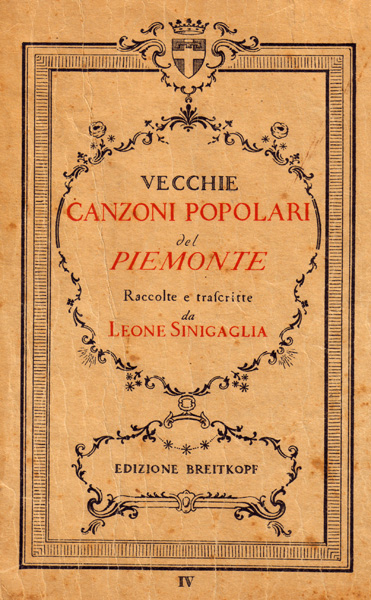
Copertina di una delle sue pubblicazioni.
Sinigaglia dedicò gli anni della maturità all'approfondimento degli
studi sul canto popolare. A questi studi attese praticamente fino alia
morte, avvenuta il 16 maggio 1944, mentre la polizia fascista lo stava
per arrestare, nell'Ospedale Mauriziano di Torino, dove si era
rifugiato con la sorella per sottrarsi alle persecuzioni razziali.
Le opere di Leone Sinigaglia - manoscritti, autografi, edizioni a
stampa - sono state affidate in deposito, dal prof. Luigi Rognoni, alla
Biblioteca del Conservatorio «G. Verdi» di Torino.
Tratto da: Leone Sinigaglia; Torino 1868-1944; Primo centenario della
nascita (1968); a cura di Carlo Mosso ed Ennio Bassi.
Leone Sinigaglia ha fatto un lavoro enorme e fondamentale perché ha
capito l'importanza della musica popolare in un'epoca in cui la gente
cantava ancora e serbava il ricordo di canti tramandati di padre in
figlio per secoli. Pochi decenni dopo, l'arrivo dei mezzi di
comunicazione di massa avrebbe accelerato il declino di un patrimonio
culturale immenso facendo, tra l'altro, scomparire l'abitudine della
gente di cantare.
Il suo lavoro è stato ripreso da molti.
In occasione del ventesimo anniversario della sua morte, è stato fatto
un disco LP a cura di Rosina Cavicchioli, mezzo-soprano e Enrico Lini,
pianista.
Le canzoni vengono presentate in veste lirica. Cosa almeno curiosa per
un canto popolare che ci si spetta fosse cantato in osteria o nelle
lunghe veglie invernali nelle stalle.
D'altra parte anche nel canto popolare c'era ci voleva fare
virtuosismi. Troviamo un passo interessante nello stesso testo
sopracitato:
[…] ottenuto che ve le cantino, si è appena al principio delle
difficoltà. Conviene raccogliere, potendo, le versioni, sovente
numerosissime, della musica e della poesia; sovente è difficile
interpretare e trascrivere esattamente la musica, se la cantano donne
assai vecchie (io radunai una volta a consiglio tre vecchie oltre gli
ottant'anni! ) - o, in ogni caso, anche se giovani, darne la giusta
divisione ritmica, sovente turbata da capricciose corone, e sceverare i
gruppetti e abbellimenti di cui il popolo volentieri fiorisce le sue
melodie, da quelli che ne sono parte essenziale. È un lavoro delicato,
complesso, lunghissimo.
Ecco un esempio.
“La Bërgera fidela” o “La pastora fedele” è una canzone molto
conosciuta in Piemonte e fa parte della raccolta di Leone Sinigaglia.
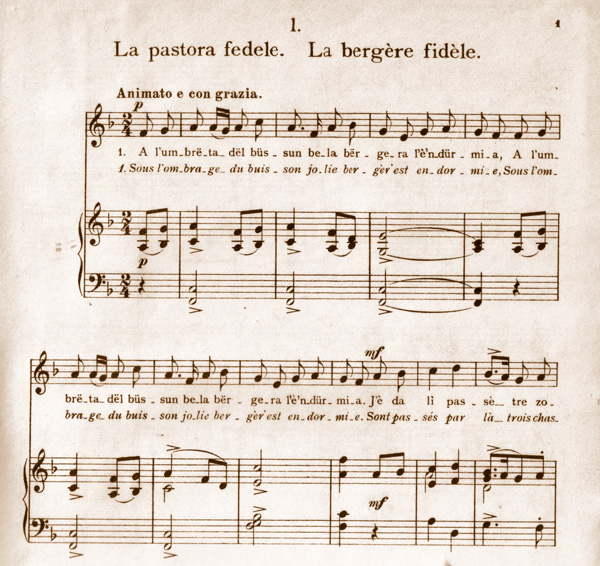
Stralcio del brano tratto dalla pubblicazione di Breitkopf.