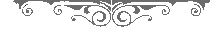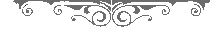Quando Giovanni Giolitti scendeva a
Pinerolo per recarsi a Cavour, il suo eremo spirituale dopo Ie dure e
alle volte drammatiche fatiche di governo, una folla di cittadini lo
attendeva sempre nella Piaz- za della Stazione. Erano in gran parte i
postulanti al cavalierato, che spiavano il momento in cui si voltava
verso di loro per lanciargli il saluto e il sor- riso propiziatorio.
Il tram a vapore impiegava sempre un po' di tempo prima di mettersi in
moto. Dalla locomotiva ansimante uscivano faville, che qualche volta si
in' castravano tra le ciglia e I’orbita dei poveri aspiranti, ma Ia
croce valeva bene un po' di bruciore agli occhi.
Giolitti dominava tutti con la sira statura - metri 1,84 -- e con quel
largo cappello da fattore di campagna. Indossava quasi sempre un tihgt
nero, che gli dava I’aspetto di un presbiteriano irlandese, e si
chinava alquanto per parlare con l'on.le Facta, piccolo, roseo,
sorridente, e con il Comm. Falco, uno degli intimi del cenacolo di
Cavour. Allora la croce da cavaliere era la mèta agognata dai buoni
borghesi e dai contadini arricchiti, qualcosa come un santo crisma che
consacrava e coonestava una vita di lavoro, senza troppe aspirazioni e
senza troppi tormenti. I Governi se ne servivano come strumento
elettorale.
Gaetano Salvemini, dopo le malaugurate elezioni del 1912 a Molfetta,
chiamò Giolitti «ministro malavita», alludendo alla corruzione
elettorale, alle pressioni dei prefetti e ai famosi mazzieri. Ma in
verità, come dimostra Giovanni Ansaldo nel suo ottimo libro «Il
Ministro della buona vita», la corruzione esercitata da Giolitti si
limitava alle elargizioni di croci. Il cavaliere, sotto il Governo di
Giolitti, come quello di Pelloux o di Saracco o di De Pretis, una volta
insignito del brillante aggeggio, si batteva per il candidato del
Governo come i cavalieri del Medio Evo per gli occhi della bella dama.
Il Pinerolese, naturalmente, rigurgitava di cavalieri senza elmo e
corazza e guai se si ometteva il titolo, parlando con un crociato del
primo novecento! Ricordo che un oste di campagna non mi servì la cena
prima che gli lanciassi un sonoro «Cavaliere». - Cavaier, c'am daga ‘na
mesa buta... E mi portò una bottiglia intera con tanto di polvere e di
ragnatele, segno di vetusta nobiltà. Motivo per cui il mio estro
maligno mi fece sfornare un sonetto che fu per me come il carmen et
error di Ovidio, vale a dire la condanna alla morte civile da parte di
tutti i cavalieri della zona. Figuriamoci! Una terzina era questa
testualmente:
Cavaier! L'ai
paura che al bechin,
Quand c'am portran
a l'ultima dimora,
Dovrò di: «Cavaier, c'am sotra bin!»
[Cavaliere! Ho paura che al becchino,
Quando mi porteranno all'ultima dimora,
Dovrò dire: «Cavvaliere, mi sotterri bene!»]
***
Ma quella sera dell'Ottobre 1911 non c’erano solo gli aspiranti al
cavalierato, ma tutta una folla straripante dai viali fino all'ingresso
della Stazione. Non solo, ma, quando dall'atrio spuntò l'imponente e
quadrata figura del Presidente del Consiglio, una banda musicale intonò
una marcia briosa che allora risuonava su tutte le piazze della
penisola.
Tripoli, bel suol d'amore...
L'impresa libica s'era già iniziata felicemente con lo sbarco dei
marinai di Cagni e i bersaglieri si inoltravano fra i meandri delle
oasi tra l'entusiasmo travolgente degli Italiani. Pascoli pronunziava
la famosa frase: «La grande proletaria si è mossa», fornendo la traccia
a tutti gli articoli e a tutti gli oratori. D'Annunzio lanciava dal
Corriere della Sera le terzine
eroiche delle Canzoni di oltre mare. Benché Giolitti avesse concepito e
attuato l'impresa solo come una
fatalità
storica,
in quanto se non andavamo noi in Libia, ci andavano gli altri, non
intendendo in modo assoluto di dare esca alle infatuazioni
nazionalistiche di Corradini, gli Italiani si accesero di passione per
questa che essi chiamavano «impresa di oltremare», sorpassando i limiti
in cui Giolitti voleva contenerla.
«L’ora di Tripoli! - scrive
Giovanni Ansaldo - fu il titolo di un volume di occasione di Corradini,
ma innumerevoli italiani credettero davvero di udirla scoccare al
proprio orologio caricato dalla Storia in persona prima». Persino il
socialismo l'aveva accolta con non eccessiva ostilità. La
Confederazione del lavoro aveva, sì, dichiarato uno sciopero generale
di protesta, ma «la protesta a braccia conserte, doveva mantenersi
dignitosa e lontana da ogni atto di violenza». Se si pensa all'ostilità
con la quale fu accolta l’impresa crispina con tanto di asportazione
dei binari per impedire la partenza delle truppe, è ovvio che -ora la -
protesta era solo
pro forma,
per salvaguardare il principio.
Strano a dirsi, solo un estremista di Forlì organizzava una lotta
violenta a base di sabotaggi e azioni di piazza. Era Mussolini, il
futuro fondatore dell'Impero!
Giolitti quella sera era reduce da Torino, dove al Regio aveva
pronunziato un discorso, confermando I’assicurazione che la guerra, ben
ristretta fra Italia e Turchia, nulla doveva innovare nel sistema
politico d’Europa. Quando sentì le note dell'inno e vide tanta folla,
guardò accigliato l'on.le Facta, come per rimproverarlo della messa in
scena. Era l'uomo di antico stampo piemontese, quanto mai alieno dalle
dimostrazioni di piazza, dalle parate e dalle cerimonie. Ma Facta non
ne aveva colpa. Egli conosceva a fondo I’uomo di Dronero e sapeva che
questi aveva fretta e che non vedeva I'ora di trovarsi a Cavour, nella
vecchia casa del nonno Plochiù, accanto a Donna Rosa e alla fida
Sablin, e poi al caffè Sociale tra la cerchia degli amici fidati, tra i
quali il buon Geom. Perassi, scomparso immaturamente pochi mesi fa.
La manifestazione era sorta spontanea dai Pinerolesi di ogni ceto, non
solo per un impeto di solidarietà per l'impresa, ma come per una
testimonianza di affetto allo statista piemontese, che essi
consideravano un po' concittadino, il concittadino che si fa onore E
avevano altri motivi d'orgoglio. L’ammiraglio Cagni era anche lui una
figura nota nel pinerolese, perché villeggiava a San Secondo, il
generale Lequio, che faceva parte del corpo di spedizione, era un
autentico pinerolese, e dalla Scuola di Cavalleria era partito anche
quel giovane Tenente, il Conte Giulio Palma di Cesnola della vicina
Bra, che assieme al Capitano Moizo volava audacemente sul deserto,
oltre Ie oasi tripoline, con quelle disastrose carcasse che erano i
primi apparecchi di guerra.
Naviga, o
corazzata,
benigno è il vento
e dolce la
stagion...
Giolitti guardò il bombardino che gonfiava le gote e aveva gli occhi
dolci come Ia stagion e alzò la mano, abbozzando un sorriso sul volto
che si spianava. Poi sali sul vecchio tram, che si mosse lentamente
brontolando come un vecchio catarroso.