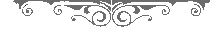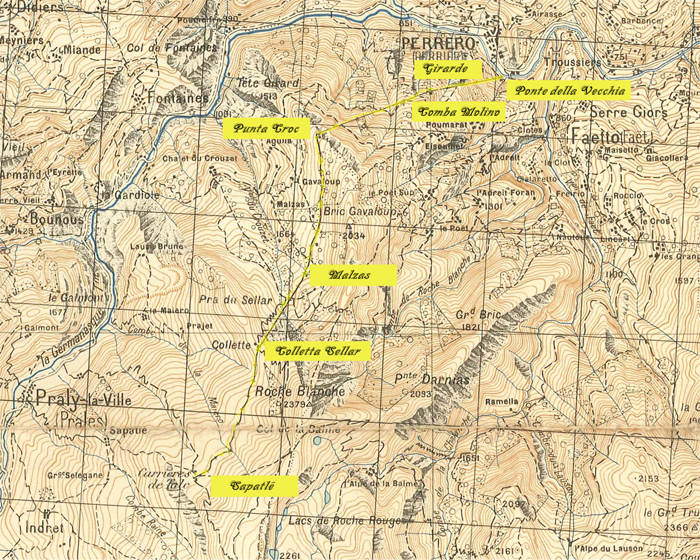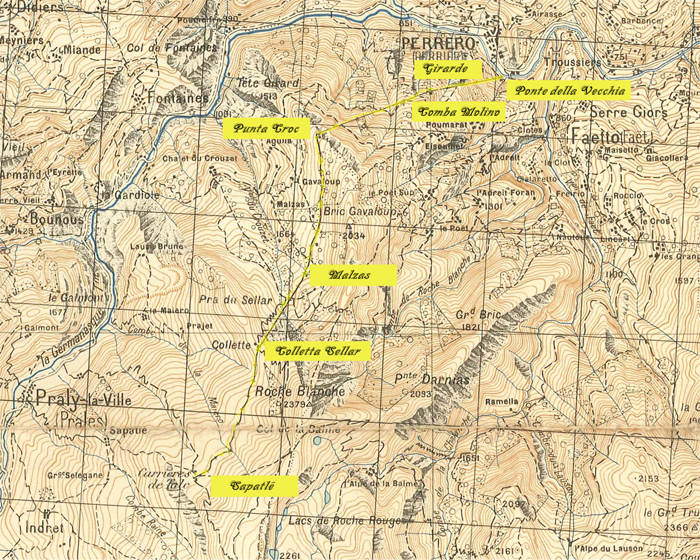Il primo che ha iniziato a
conglobare in un’unica organizzazione varie miniere preesistenti e a
acquisire diritti da vari proprietari di terreni è stato il conte
Enrico Brayda di Ronsecco che negli ultimi decenni dell’800 ha fondato
la “Enrico Brayda & C.”
Il Brayda apriva o espandeva le zone
minerarie di Envie, Sapatlé e Malzas. Tutti siti ad alta quota – tra i
1800 ed i 2000 metri – per cui si poneva in maniera importante il
problema del trasporto a valle del minerale.
Oggi è persino
difficile rendersi conto dell’importanza di questo problema. Abituati
come siamo a andare ovunque in breve tempo, e senza fatica, alla guida
di un’automobile e percorrendo comode strade asfaltate, non pensiamo
più che all’epoca dei nostri nonni o bisnonni tutto ciò non esisteva.
Alla
fine dell’800, la strada per Prali che oggi conosciamo, non esisteva.
La sua costruzione sarebbe iniziata solo agli inizi del ’900. Per cui,
oltre a non esistere mezzi motorizzati in grado di spostare carichi
significativi, non c’era neanche una strada così come la pensiamo oggi.
La vecchia strada per Prali, che per l’epoca era piuttosto ampia, vista
oggi ci sembra una mulattiera di modeste proporzioni. Se ne possono
ancora percorrere ampi tratti a partire dal ponte di Pomeifré subito
dietro la zona mineraria attualmente attiva passando per Saut dâ
Loup dove si possono ancora vedere i solchi lasciati nella pietra dal
passaggio dei carri, oppure a monte di Scopriminiera sul tratto che
conduce a Prali passando per
Roccho
Eiclapâ,
che è stato risistemato negli ultimi anni e che, attraversando il rio
di Rodoretto ed il Germanasca, porta sulla destra orografica dove
procede fino a Ghigo. È importante fare queste passeggiate! Sono
piacevoli e consentono di capire come veramente ci si muoveva prima
dell’era del motore.
Ebbene, il talco, che sarà anche morbido ma è
sempre una pietra che come tale pesa, veniva estratto a circa 2.000
metri di quota a Envie o Sapatlé, oppure a circa 1800 metri di quota ai
Malzas, e poi doveva essere trasportato a valle o a spalle nelle gerle
o in sacchi di iuta disposti su slitte che venivano trainate sulle
mulattiere prima e poi sulla vecchia strada di Prali fino alle vie di
comunicazione principali in bassa valle dove si cominciava a poter
usare dei carri a trazione animale.
Il trasporto era quindi estremamente lento e costoso.
Il
conte Enrico Brayda che, stando alle memorie di
Damiano Sartorio,
era molto in gamba, anche se un po’ megalomane, concepì un impianto
gigantesco ed avveniristico che avrebbe permesso di portare a valle il
talco in modo più efficiente. Pensò infatti che l’uso di teleferiche e
Decauville avrebbe permesso di migliorare enormemente i trasporti.
Vista
oggi, questa non sembra una grande intuizione. Ma occorre pensare che i
cavi d’acciaio sono stati inventati solo negli anni '30 dell'800
dall'ingegnere minerario Wilhelm Albert, rendendo possibile la
costruzione di impianti a fune. Cosa che le vecchie funi di canapa non
avrebbero permesso. Del resto l’unica alternativa disponibile era la
catena metallica che però era soggetta a rotture improvvise e del tutto
imprevedibili.
Inoltre risaliva solo a di quegli anni
l’invenzione delle ferrovie a scartamento ridotto dette
Decauville dal
nome dell'inventore. Prima di allora, le ferrovie – sia quelle grandi
per i treni che quelle a scartamento ridotto per trasporti locali –
venivano costruite assemblando sul posto le rotaie sulle traversine con
tutta la ferramenta necessaria per il montaggio.
Ainé Decauville
ebbe l’idea di costruire tranci di binario assembrato in fabbrica di
dimensioni e peso tali che un operaio potesse spostarli agilmente da
solo. Questo consentì una riduzione radicale dei costi di realizzazione
di ferrovie a scartamento ridotto e un considerevole aumento della
velocità di realizzazione. Nel manuale “Lavori di Terra” di Giovanni
Martelli del 1881 l'Autore evidenzia che 4 operai potevano traslare di
30 metri un tratto di ferrovia lungo 400 metri in 1 ora e 15 minuti.
Chiarito
questo, ci si rende conto che l’idea di Brayda era veramente innovativa
e faceva uso di tecnologie e idee avanzatissime. Per di più prevedeva
di usarle su una scala enorme che solo una mente fervida e forse un po’
troppo entusiasta poteva immaginare.
Fatto sta che Enrico Brayda ha dato all’ingegnere inglese Carrington
l’incarico di progettare l’impianto.
Il
progetto prevedeva la partenza da Sapatlé (2070 m) con una
Decauville
che arrivava alla Colletta Sellar; una teleferica che discendeva alle
miniere di Malzas (1797 m), un’altra
Decauville
fino a Punta Croc e
altre due teleferiche delle quali la prima arrivava a Comba Molino e la
seconda al Ponte della Vecchia a Perrero (800 m), passando su un
cavalletto posto alle Girarde.
L’investimento venne fatto
dall’imprenditore di Savigliano Avv. Grandi che poi affittò l'impianto
alla Brayda
& C. Non è chiaro il motivo di questa scelta.
Fatto sta che il
23 Ottobre 1893 l’impianto venne inaugurato con una grande festa. La
sera precedete le varie stazioni erano state illuminate con dei falò,
mentre il cielo era illuminato da fuochi d’artificio e bengala.
Il
conte Brayda in persona inaugurò l’impianto scendendo da Comba Molino
in una benna illuminata da due bengala. Forse
Damiano Sartorio aveva le
sue ragioni a considerare il Brayda un tantino megalomane…
Ma la cosa ebbe una vasta eco fra la gente che accorse numerosa ad
applaudire all’iniziativa.
L’impresa
poté essere realizzata grazie al contributo del Genio Militare che era
interessato all’iniziativa, vedendone possibili usi bellici. Parte dei
lavori venne infatti effettuata dal capitano Albarello della Direzione
di Artiglieria di Torino. Stando all'
articolo
di Luigi Timbaldi in ricordo di
Damiano
Sartorio, l'esercito aveva sostenuto l'iniziativa in cambio della
possibilità di usare il sistem di trasporto per costruire i
Ricoveri Perrucchetti ai
Tredici Laghi.
Non sono noto altri usi importanti del Gran Courdounn da parte delle
forze armate. Caso mai dai partigiani durante la
Resistenza.
In merito al coinvolgimento dell'esercito nella relauzzazione
dell'impianto si possono aggiungere due
osservazioni.
La
prima è che la zona di massimo interesse militare
era il vallone dei
Tredici Laghi
che era di difficilissimo accesso a
causa della mancanza di una strada carrozzabile per Praly. La zona era
talmente importante che, per raggiungerla, nei decenni successivi
sarebbe stata realizzata un’altra opera gigantesca: la strada della
Conca Cialancia che, seppure mai completata, avrebbe dovuto
permettere di raggiungere i
Tredici
Laghi con i mezzi motorizzati
partendo a valle di Perrero [I lavori vennero sospesi a Conca Cialancia
(2451 m) per mancanza di denaro e di motivazioni strategiche nel 1942].
Poter arrivare con carichi fino a
Sapatlé avrebbe radicalmente agevolato le operazioni militari. Da cui
l’interesse per l’iniziativa. Del resto è anche vero che la maggior
parte delle teleferiche non era motorizzata. Dato che dovevano
trasportare talco solo in discesa, funzionavano a gravità. Per cui le
possibilità di sollevare carichi erano limitate da quanto si poteva
alzare sfruttando il carico della benna discendente che era di circa
400 kg.
La seconda osservazione è che l’intervento militare nella
realizzazione dell’impianto riduceva il peso dell’investimento a carico
dell’impresa da cui il vantaggio di coinvolgere la Difesa nella
realizzazione dell’opera.
La storia dell’impianto è condita di pettegolezzi…
Il
Gran Courdoun è stato proposto la prima volta nel 1880 dal conte Enrico
Brayda, allora direttore degli impianti. Era un tecnico formidabile e
aveva il merito di vivere le miniere insieme al resto del personale
benché riservandosi una residenza più confortevole. Gorge Huntriss,
presidente della Anglo Italian Talc & Plumbago Mines Company ha
bocciato l’iniziativa in quanto troppo costosa.
Ma Enrico Brayda ha trovato rapidamente la soluzione al problema.
Ha
chiesto ad un altro imprenditore suo amico, il sig. Grandi, di
costruire lui, a sue spese, l’opera e poi di affittargliela; cosa che
poteva decidere senza l’approvazione di Huntriss.
Non sono passati
molti anni che Huntriss è piombato in Italia con fieri propositi e ha
licenziato il Brayda e San Martino - l’altro socio - assumendo, lui
direttamente, la direzione della società.
Comunque sia, il sistema è
stato poi acquisito dalla Anglo Italian Talc & Plumbago Mines
Company è funzionato dal 1893 al 1961 con ottimi risultati. È stato poi
smantellato ma le stazioni principali e i tracciati delle
Decauville
sono tutt’ora visibili.
Ma in questa storia c’è qualcosa che non quadra.
L’inaugurazione
del Gran Courdoun è avvenuta anni prima della fondazione della Anglo
Italian Talc and Plumbago Mines Company Ltd. Avvenuta nel 1897
[documenti disponibili presso i National Archives del Regno Unito]. Per
cui il fatto descritto da Damiano Sartorio “non funzionerebbe”. O
George Huntriss era già azionista della Brayda & C o c’è qualcosa
che non torna con le date…
Malzas.
Foto del 2006.

Stesso luogo quando era ancora in attività.
La foto è a dir poco rara nel senso che
Piero
Sartorio
che l'ha fatta non l'aveva mai vista! Lui aveva fatto due foto distinte
i cui negativi sono arrivati fino a noi. Scannerizzati e assemblati con
software da foto panoramiche – e un tot di smanettamento... - hanno
dato questo risultato.
A monte dell'edificio si notano delle persone su una
decauville. In basso a
destra dei panni
stesi.
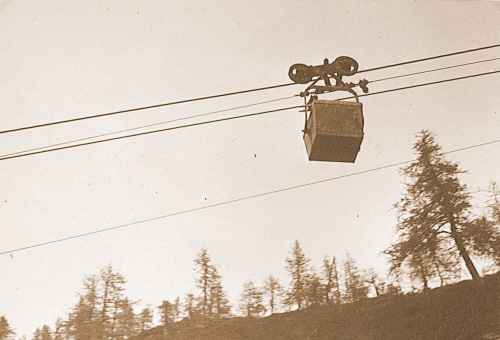 Il
mio lavoro mi portava sovente tra le montagne e questo ha fortificato
l'affetto che portavo per quei luoghi ed anche per le modeste
installazioni industriali che li caratterizzavano. Questo è un carrello
della teleferica di Colletta Sellar in prossimità della stazione
inferiore di Malzas.
Il
mio lavoro mi portava sovente tra le montagne e questo ha fortificato
l'affetto che portavo per quei luoghi ed anche per le modeste
installazioni industriali che li caratterizzavano. Questo è un carrello
della teleferica di Colletta Sellar in prossimità della stazione
inferiore di Malzas.
Foto e note di
Piero
Sartorio; 1940.

Malzas nei pressi della stazione della teleferica.
Foto del 2006.

Malzas teleferica nel 1893.
Fonte: Come Vivevano… Pinerolo val Chisone e Germanasca fin de siècle
(1880-1920);
Claudiana
1990

Malzas.
Foto del 2006.

La decauville è diventata un sentiero..
Foto del 2006.

Il piano inclinato che sale dalla miniera San Carlo scavalca la
decauville del Gran Courdoun.
Foto del 2006.

Qui
mancano note di Piero Sartorio. Dovrebbe trattarsi di un'immagine anni
'40. Rende l'idea di cosa voleva dire spostare carichi sulle decauville
in inverno.
Foto di
Piero Sartorio;
1940 circa.


Vecchi vagoncini trasformati in fontane.
Foto del 2006.

Punta Croc.
Partenza della seconda teleferica.
Foto del 2006.

Punta Croc.
Partenza della seconda teleferica nel 1893.
Fonte: Come Vivevano… Pinerolo val Chisone e Germanasca fin de siècle
(1880-1920);
Claudiana
1990

Punta Croc.
Vista dalla partenza della seconda teleferica.
Foto del 2006.

L'età dell'impianto è evidenziata dalla forma dei dadi che erano
quandrati mentre oggi sono esagonali.
Foto del 2006.

Punta Croc.
Rullo per la guida della fune traente.
Foto del 2007.

Punta Croc.
Dettaglio
del rullo per la guida della fune traente. Una settantina d'anni di
onorato servizio hanno lasciato il segno della fune inciso nella gola
in ghisa.
Foto del 2007.

Illustrazione di un rullo di guida per fune traente tratto da:
Come si progetta e si costruisce una teleferica per il trasporto di
merci e di persone
Ing. Prof. Odoardo Harley di San Giorgio
G. Lavagnolo Editore.
Torino 1937
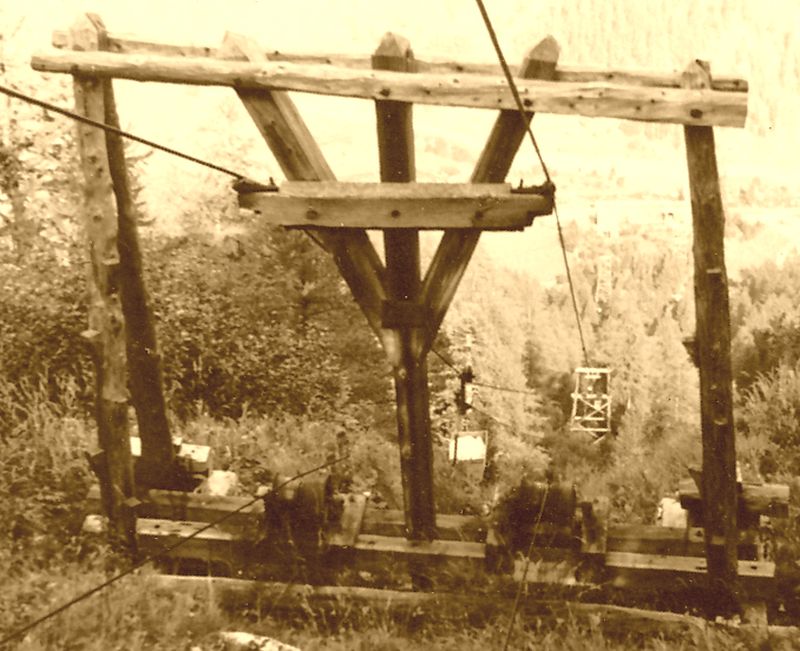
Ed ecco due rulli in funzione in una foto di
Piero Sartorio.

Punta Croc.
Pulegge di monte della teleferica.
Foto del 2010.
Le
pulegge che possono ancora essere viste alla partenza della teleferica
sono scampate ai lavori di demolizione degli impianti appaltati negli
anni '60 alla ditta San Martino. Probabilmente erano troppo pesanti per
essere trasportate a valle e vendute come ferro vecchio.
Sono
entrate in funzione nel 1892 e dopo una settantina d'anni di onorato
servizio e mezzo secolo di abbandono alle intemperie restano in ottime
condizioni e non presentano rotture significative.
Osservandole, si può notare un particolare interessante. Sono fatte in
un solo pezzo ottenuto per fusione in uno stampo.
Ma
la fusione di pezzi di così grosse dimensioni, e di questa forma,
generalmente generava delle tensioni nel metallo che facilmente
portavano a rottura già sul pezzo nuovo o comunque nei primi tempi di
funzionamento.
Per ovviare a questo inconveniente la tecnica, in uso
ancora fino alla metà del XX secolo, era quella di spezzare le razze a
mazzate appena la puleggia veniva estratta dalla fusione e poi brasarle.
La brasatura, come la saldatura, è un'operazione che serve per unire
due parti metalliche.
Nella
saldatura, il metallo di apporto può non essere previsto (saldatura a
punti) oppure è lo stesso del materiale costituente i due pezzi da
unire.
Nella brasatura il metallo di apporto è di tipo diverso.
Le
due tecniche vengono usate in funzione del tipo di materiale da unire,
della finitura estetica richiesta, e della possibilità, per il pezzo da
saldare o brasare, di essere portato a temperature elevate.
Spezzare e
poi brasare le razze delle pulegge aveva quindi la funzione di
eliminare qualsiasi tipo di tensione interna al metallo e prevenire
rotture in funzionamento.
Le pulegge del Gran Courdoun non presentano alcuna
brasatura. Chi le ha fatte nel lontano 1892 era un “mago” della
siderurgia che verosimilmente è riuscito a fare raffreddare le fusioni
in tempi lunghissimi ottenendo questo eccezionale risultato ancora
visibile ad oltre un secolo di distanza.